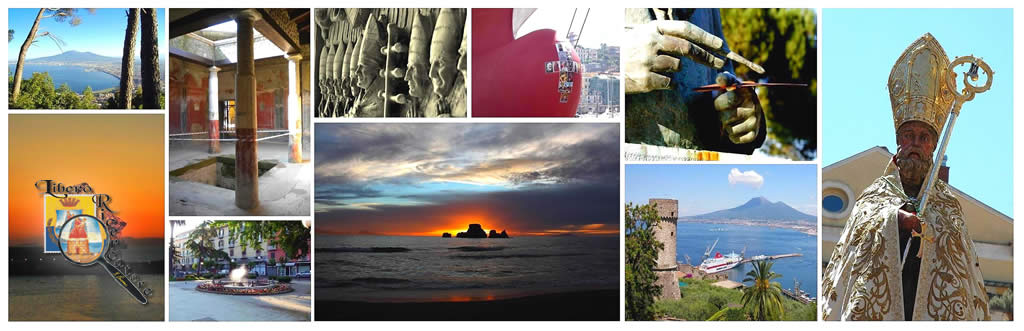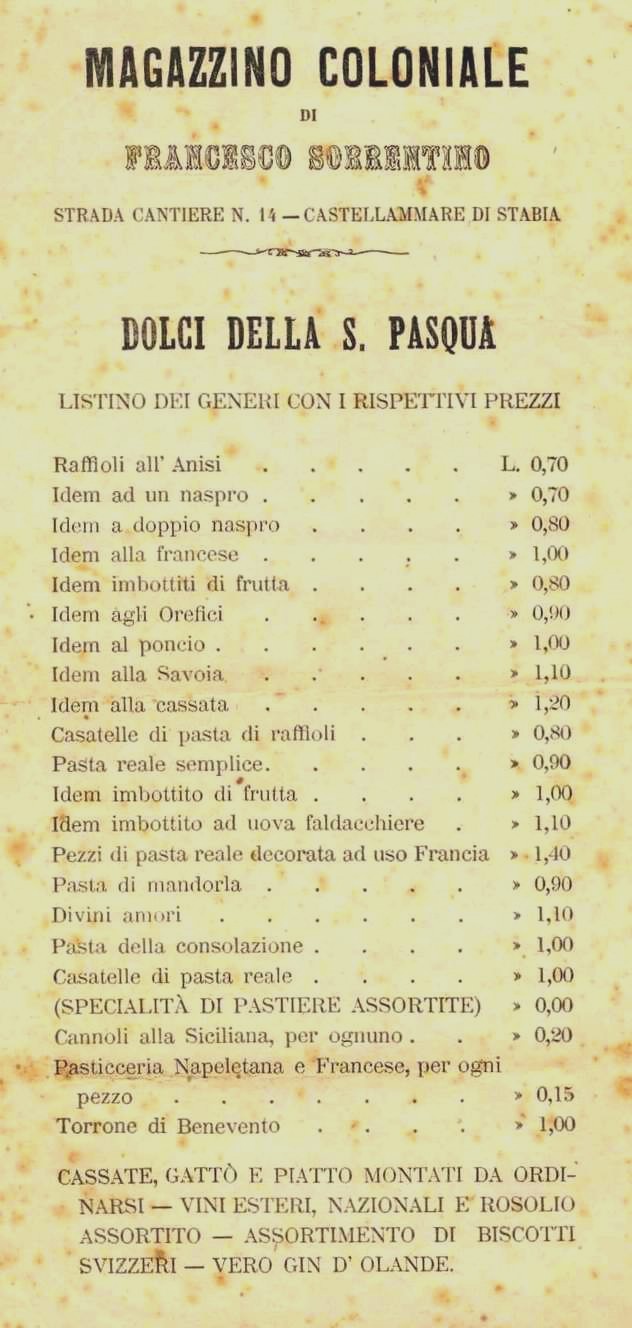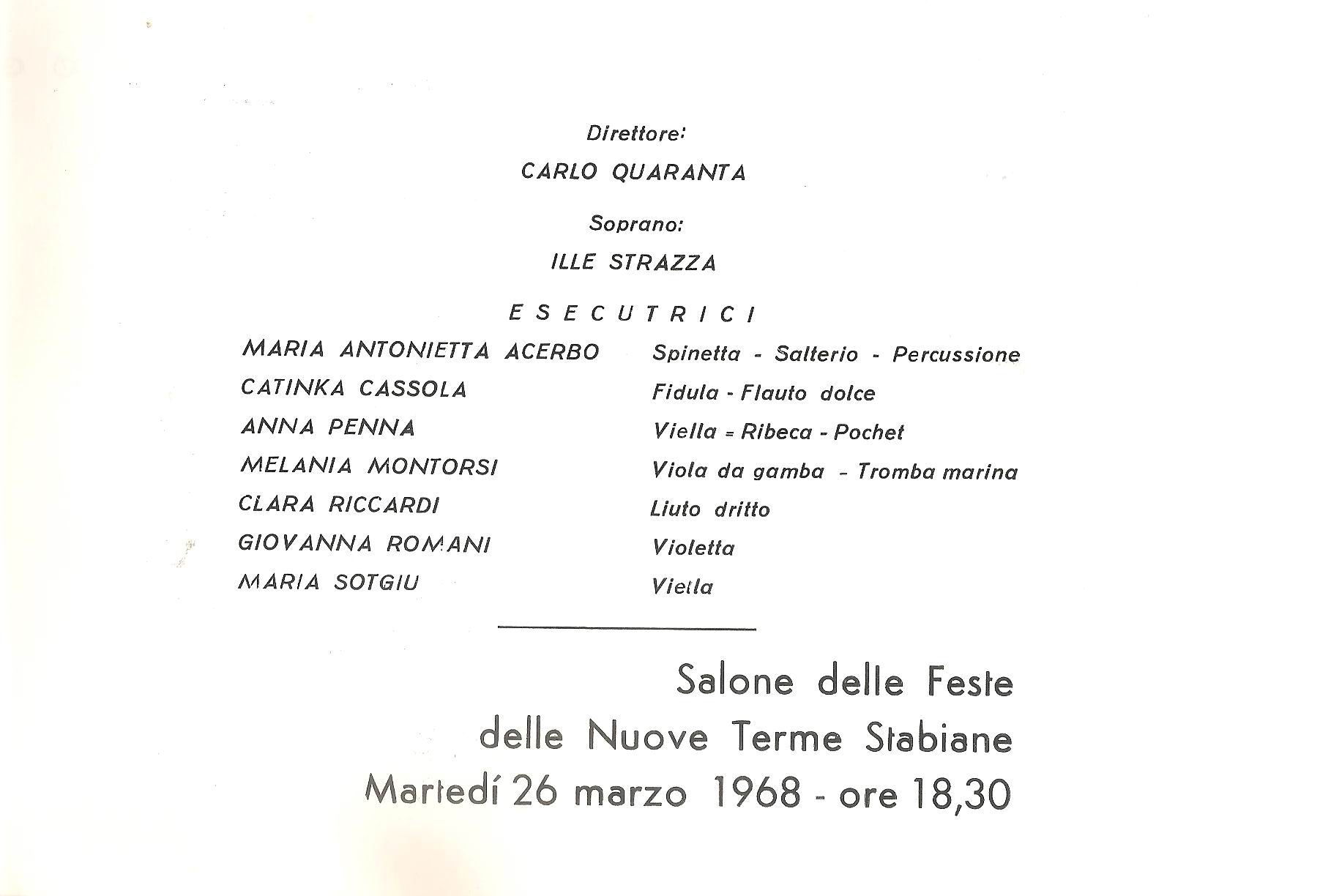Per il piacere di conoscere e per meglio comprendere le tradizioni locali, proponiamo la “Canzone de lo Capo d’Anno”, un’antica ballata tradizionale: il sacro e il profano che si fondono, narrato dai cantastorie popolani.
Maurizio Cuomo
La Canzone de lo Capodanno
(nota descrittiva del prof. Luigi Casale)
La “Canzone de lo capodanno” è un lungo canto augurale: il genere letterario è “la ‘nferta” (l’offerta), che i musici portavano alle famiglie, nei giorni delle feste natalizie e di fine d’anno. Per la sua lunghezza appare quasi una sceneggiata. In alcuni centri della penisola sorrentina e della costiera amalfitana, in particolare a Maiori o a Piano di Sorrento, dove se ne attribuisce la paternità a un loro concittadino, è l’intera comunità locale a parteciparvi. Mentre nelle città più grandi generalmente la si canta in famiglia, nelle case. O anche nei cortili con la partecipazione delle famiglie del vicinato.
Questa ‘nferta natalizia, nel testo tramandatoci dal Croce, è un componimento molto raffinato, ben strutturato, che, per scelta linguistica, e contenuti del tema, presuppone un autore acculturato, vigile, intelligente, del cui nome purtroppo si è perduta la memoria. Essa passa per anonima, perché anonima era la copia a stampa che veniva fatta circolare per Natale, e che, come tale, è stata trovata nella raccolta di cose semplici della biblioteca di Benedetto Croce tra testi ben più importanti. Meritevoli tuttavia di riguardo.
Con questo canto, nel chiedere l’offerta, gli “amici buontemponi” portano gli auguri per il nuovo anno a un destinatario di loro conoscenza del ceto sociale non meglio identificato.
Il canto si apre con l’annuncio che si è giunti al termine dell’anno e bisogna perciò trascorrere la notte in allegria. Continua poi, per una settantina di strofe, toccando diversi punti: il mito, la storia, la realtà quotidiana di paese, il sentimento religioso, l’espressione degli auguri a tutte le professioni; e si conclude con l’intenzione della dedica e con la richiesta di un’offerta, insieme alla speranza di vedersi ancora l’anno prossimo in condizioni di maggior benessere morale e materiale (la sostanza degli auguri!).
A leggerla oggi, la Canzone sembra composta da un fine osservatore dei tempi moderni, acuto e brillante al tempo stesso, brioso e caustico come deve essere un autore seriamente (e coscienziosamente) satirico.

Pazzariello napoletano
E concludo. La migliore offerta – insieme ai voti augurali – che l’estensore di queste note può donare ai suoi amici, anonimi lettori, è quella di porgere ad essi il testo della Canzone nella versione più diffusa, quella che ci è stata conservata dal Croce.
L’introduzione è un recitativo di due strofe di endecasillabi (ad eccezione del primo verso della seconda strofa che si presenta come un verso doppio, formato cioè da due settenari).
Seguono 69 quartine (tre settenari, più un quinario). Il secondo e il terzo verso di ogni strofa rimano tra loro; l’ultimo rima col primo della strofa successiva, creando un concatenamento di tutto il canto. Durante l’esecuzione, divenuta classica, lo stesso richiamo dei due semicori alternati, ne sottolinea la unità compositiva.
L’intonazione è data dal corifeo che imposta ogni strofa melodicamente, evidenziandone il tema musicale. Dopo una ripresa del primo semicoro (che ripete l’ultimo verso), i due gruppi, uniti riprendono i due ultimi versi della strofa.
Canzone de lo Capo d’Anno
Coro d’introduzione (parlato)
A. La bona notte e buon principio d’anno
A tutti sti signuri in compagnia !
Simmo venuti e tornarrammo ogni anno
Per farve chill’aurie che sapimmo.
B. Spilateve lli rrecchie, apritece lu core
La casa, la dispensa e la cantina
Ca cheste so ghiurnate de cuntiente
Se magna e beve e non se pensa a niente
– – –
Testo originale (cantato)
1. Aprimmo l’anno nuovo
Co tric-trac e botte
Passammo chesta notte
In allegria.
2. Nascette lu Messia
Avenne poveriello
No voje e n’aseniello
Pe vrasera. Continua a leggere→