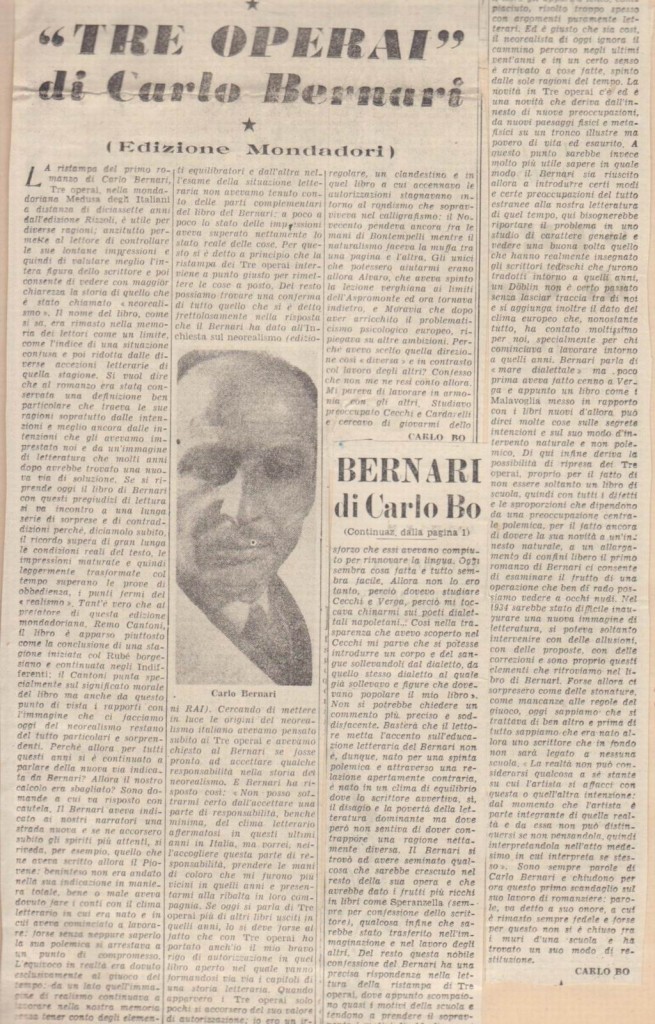( Il prof. Luigi Casale incontra il professore Antonio Carosella )
Quella che si narra in questa pagina sicuramente non è una storia minima!
Quando il professore Antonio Carosella l’estate 2010 volle offrirmi la sua raccolta di “scritti vari” dal titolo Apis more modoque, mi sorprese la mole del volume, che subito pensai, riconoscendomi – in tutta franchezza – un cattivo lettore, lento e indolente, che molto probabilmente non l’avrei mai letto o che forse una volta iniziatane la lettura – bontà mia! – non l’avrei portata a termine. Ebbene, a questo pensiero mi sentivo davvero indelicato verso chi avevo voluto incontrare dopo più di quarant’anni dalla nostra separazione alla fine della “maturità” liceale. Come avrei potuto riservargli un comportamento tanto irriguardoso a fronte di tutte le cortesie ricevute? Con quale coraggio?
Per la verità, lasciata la scuola alla fine dell’anno scolastico 1963/64, c’eravamo incontrati un paio di volte.

anno scolastico 1963/64
La prima fu un incontro occasionale, per strada. La seconda, che io ricordi, fu un incontro molto più significativo. Era il 16 aprile del 1972. L’indomani del mio matrimonio. A mezzogiorno partivo da Napoli in viaggio di nozze con destinazione Verona. Rapido, prima classe, ristorante a bordo, credo che si chiamassero “treno bandiera”: proprio come si conveniva a due sposini in luna di miele. I fatto è che all’epoca essendo io funzionario delle FS, a parte il pranzo, beneficiavo insieme alle persone a carico – come si dice con linguaggio burocratico – delle cosiddette concessioni ferroviarie.
Con quello stesso treno si trovava a viaggiava il professore Antonio Carosella – adesso non ricordo se diretto a Roma oppure a Bologna. Ricordo solo che date le circostanze, fu per me un viaggio piacevole e memorabile. La sua compagnia fu gradita anche a mia moglie, che poté conoscerlo e ammirarlo.
In seguito, ma ormai erano passati diversi anni: si era nell’anno scolastico 1988/89, c’era stata una sua telefonata, graditissima, con la quale egli, avendone avuta notizia dal prof. Centonze o dal comune amico Eugenio De Biase, si complimentava del mio incarico di preside al Liceo Virgilio di Vipiteno.
Perciò verso chi, nel rivedermi ora dopo tanto silenzio, mi aveva accolto con entusiasmo e generosa affabilità, apparivo a me stesso uomo poco riconoscente, ingrato. E neppure compensava il rammarico, il fatto che insieme a quel malloppo di libro, nel dono, vi erano altre due o tre delle sue opere le quali avrebbero attirato la mia preferenza verso una lettura attenta e interessata, anche con una certa urgenza e frenesia. Il romanzo Il ritorno, l’avei letto per studiarne la prosa narrativa. Trittici vesuviani, trattandosi di pagine critiche sulla narrativa campana degli ultimi anni, l’avrei letto per mia personale informazione storico-letteraria, ma soprattutto per risentire l’eco delle grandi lezioni a cui ci aveva abituato il professore Carosella nei corsi liceali. E poi volevo leggere dei due romanzi già pubblicati da Vincenzo Esposito, compagno di classe, e ugualmente suo alunno. Terzo: Gaetano Pagano, una vita per la poesia, lo ritenevo interessante per avvicinarmi ad un poeta per me nuovo e sconosciuto, sebbene tanto vicino. Questi tre libri, per numero di pagine, si presentavano inoltre molto più agili e leggeri.
Ma adesso – vista la cosa dalla prospettiva dell’oggi – devo dire, “agili e leggeri” solo nella veste esterna. Proprio perché, dopo, avrei dovuto ricredermi. Su di essi e sull’altro, Apis more modoque.

copertina
Sì, è vero. Il modo di presentarsi (insieme alla stessa particolarità del tema indicato nei titoli) di quei tre volumi “più agili” facilita, anticipandola, la percezione della unitarietà, dell’organicità e della coerenza della singola opera. Ora però posso dire che, quanto a questo, non è dissimile (se si esclude l’elevato numero di pagine: 740) neppure il soggetto, il tema di fondo, di Apis more modoque (e che comunque il titolo stesso riassume). Perciò quelle prerogative di unità e di coerenza che si richiedono alla scrittura, le mantiene intatte, se solo si rifletta che il tema centrale del libro è la vita stessa, di insegnante, di educatore, di cittadino, di chi ha voluto pubblicarlo. E infatti proprio di questo si tratta: di una testimonianza forte e vigorosa, organica e coerente, unitaria come la vita del suo Autore che quelle cose ha scritto, sebbene distillate e raccolte in una modalità di scrittura parcellizzata, estemporanea, occasionale, e ben finalizzata.
La rivalutazione dell’opera (che in seguito, considerata la sua finalità e la stessa organizzazione interna dei materiali, ha consentito anche e me, lettore lento e indolente, un approccio ordinato e mirato, già quasi uno studio) si è presentata quando, leggendo qualcuno degli interventi, vi ho scoperto la profondità del pensiero e l’altezza dell’eloquio del Carosella. Confermando così un mio giudizio sulla persona, sulla sua opera e sulla sua scrittura, che conservavo in pectore.
* * *
Ma, allora, che cos’è Apis more modoque? Prima l’ho chiamato “malloppo”. E tuttavia nell’apparente linguaggio scherzoso si nascondeva una punta di verità, se per malloppo si intende un bottino, più o meno prezioso, comunque di valore e di peso.
Una possibile traduzione del titolo potrebbe essere: “A poco a poco come fanno le api”. Le quali prendono un po’ di qua e un po’ di là dai fiori la sostanza che poi trasformano in miele e altre cose utili e nutrienti. Ecco, detto così, sembra sufficientemente chiarito il senso della metafora. Ma se l’attività delle api rappresenta il modo in cui la raccolta di scritti è andata formandosi, il prodotto, in questo caso il volume a stampa, corrisponde al miele: una dolcezza che nutre e piace. O meglio, “una dolcezza che piacendo nutre”. E infatti è questa la funzione del libro, e tale dovrebbe essere il motivo che deve spingere le biblioteche a non privarsene e i lettori a non rinunciare alla sua consultazione. Innanzitutto le biblioteche scolastiche e quelle di carattere popolare e divulgativo come la nostra – del Liberoricercatore – “Biblioteca stabiana”.
Ad incoraggiarci a questa amabile frequentazione con le pagine di Apis more modoque, ci aiutano i due scritti introduttivi: la presentazione di Salvatore Ferraro e la prefazione dello stesso Carosella. Ma poi una volta addentrati nella lettura, scopriremo da soli il significato della raccolta e la sua validità come testimonianza, come documento storico, come tesoretto di valori civili e valori morali. Giovani, studenti, insegnanti, genitori, amministratori pubblici, cittadini, chiunque si senta impegnato a realizzare per sé, per i suoi, per la città, un vita degna e dignitosa, nobile della nobiltà dello spirito, vi troverà spunti di riflessione e dati importanti per la conoscenza della storia civile e culturale della comunità scolastica (e dintorni) negli ultimi 50 anni, dagli anni delle tensioni politiche, a quelli del degrado, fino a quelli della riscossa verso un nuovo umanesimo. Il primo scritto data 1960; il libro è uscito nel 2008.
La struttura dell’opera è lineare. Raccolti in quattro sezioni, gli scritti seguono l’ordine cronologico della loro pubblicazione, senza nessun ulteriore commento; a parte qualche isolata nota di chiarimento e di contestualizzazione dell’avvenimento richiamato nel testo. Le sezioni sono: Interventi critici [interventi critici, presentazioni, recensioni, mostre di pittura, lusus latinus (testi in latino)]; La scuola e i giovani; La presenza nella vita cittadina; La militanza rotariana.
L’opera si conclude con un’appendice di lettere scelte indirizzate ad Antonio Carosella in circostanze varie.

a sinistra il Prof. Casale a destra il Preside Carosella
Per quello che significa, ci auguriamo che questa pubblicazione insieme a tutta la produzione letteraria del professore Carosella possa entrare quanto prima nella piccola Biblioteca stabiana del Liberoricercatore, a testimonianza della sua contiguità, attenzione e simpatia verso il mondo della scuola e verso i suoi operatori, come il professore Carosella, che ne fanno la storia.
Luigi Casale.